L’incontro con lo scrittore Walter Siti, premio Strega 2013 e autore di I figli sono finiti, uscito quest’anno per Rizzoli, è il primo evento di Salerno Letteratura al quale ho assistito. Chiesa dell’Addolorata. Walter Siti appare in orario, solo che – ahimè – è in video, in collegamento da remoto. Poco male: le cose che dice, da subito, colpiscono nel segno. Siamo davanti a un vero scrittore. Quando succede, te ne accorgi dal modo di parlare diverso da quello di un comune mortale, perché l’eloquio è raffinato e chiaro e il contenuto stimolante. Del resto, come diceva Karl Popper, “chi ha da dire qualcosa di nuovo e di importante ci tiene a farsi capire” e gli scrittori (quelli veri) di solito hanno cose nuove e importanti da dire (dovremmo ascoltarli di più).
Walter Siti: I figli sono finiti e l’incontro tra generazioni antitetiche

Nel suo romanzo, Walter Siti mette in relazione due generazioni antitetiche: quella cui appartiene Augusto, settantenne cardiopatico che ha perso il compagno tragicamente e che vive proiettato verso un irraggiungibile esterno, e Astore, rappresentante della GenZ, nato nel 2002, la cui vita è un costante ripiegamento verso l’interno. Augusto, che non può uscire, vorrebbe vivere nel mondo, Astore, invece, vorrebbe isolarsi da tutti. Il rapporto tra i due si svolge sullo sfondo di un mondo in perpetua trasformazione (quello della pandemia da Coronavirus, tra l’altro, ma non solo), dominato da una tecnologia subdola, fatta di reti sociali virtuali, intelligenza artificiale e realtà filtrate, subdola perché impattante sul nostro modo di vivere ma in maniera sempre più impercettibile, quasi parassitaria, tanto che diventa impossibile difendersi.
Piccola digressione. In collegamento, Walter Siti ha fatto una riflessione sulla scrittura e sui lettori che approvo pienamente: il valore principale di un romanzo è dato dallo stile, è da quello che si capisce, in realtà, come uno scrittore la pensa. Anche per me, lo stile è fondamentale, molto più dell’intreccio. Sarà per questo che amo pazzamente quegli autori che dello stile hanno fatto una vera e propria firma: Faulkner, Nabokov, Fante, Fitzgerald, Austen, per citarne alcuni.
“Lo scrittore che chiama zappa una zappa dovrebbe essere costretto ad usarla”.
(Oscar Wilde)

Ad ogni modo, la riflessione principale che l’incontro con Walter Siti mi ha scatenato, riguarda l’impatto che le nuove tecnologie (social media su tutte) hanno avuto sulla nostra vita, cambiandola al punto da definire non solo nuovi modelli ma anche nuovi valori, nuovi modi di pensare e di essere.
Walter Siti ha detto una cosa che mi ha fatto pensare (cito a memoria): “Sono rimasto molto colpito all’idea che esistano in rete fotografie di persone che in realtà non sono mai esistite, perché prodotte dall’Intelligenza Artificiale“. Una constatazione semplice e, allo stesso tempo, disturbante.
Viviamo in una realtà dicotomica
La nostra nuova realtà è dicotomica, in parte originale e in parte ricostruita, in maniera così sapiente che è quasi impossibile dividere l’analogico dal digitale, i pori dai pixel. Dovremmo zoomare tantissimo e con mezzi via via più potenti per individuare la linea di cesura. Diventa sempre più difficile. Il perché dovremmo fare una cosa del genere, sempre più irrilevante. Il pensiero critico, che comporta uno sforzo non indifferente, è destinato a morire, a vantaggio di forme di pensiero apparentemente più stabili e rassicuranti, ma di fatto illusorie e tossiche. I social media si autoalimentano di paradigmi impossibili: un’idea di felicità perpetua, che non ammette crepe, come un viso non ammette imperfezioni.
Sono cambiati i punti di riferimento e cambiano i valori, di conseguenza cambiano gli obiettivi e i mezzi per raggiungerli. Per fare un esempio: le storie d’amore possono nascere online, vivere online e morire online: il linguaggio amoroso è cambiato, ora è scandito da like messi o tolti, ex bloccati/cancellati, storie guardate, sexting e poi ghosting, tradimenti virtuali.
Cambiano le relazioni, sia interne (familiari) che esterne. Tante persone, ormai, scattano foto non per ricordare quanto per ricevere approvazione, ragazzini di dodici anni indossano gli stessi abiti e assumono le pose di influencer che hanno il doppio dei loro anni perché il modello di bellezza (=successo) non è più l’attore o l’attrice hollywoodiana, lontanissima, baciata dalla fortuna, irraggiungibile e invidiabile, ma la ragazza/il ragazzo della porta accanto bellissima/o e di successo, grazie ai filtri, applicati e poi dimenticati, come se il risultato finale – fake – annullasse la “difettata” realtà di partenza. Allarmante non è il fatto che si viva applicando filtri alla realtà, ma che si viva dimenticando di aver applicato dei filtri. Perdendo il contatto col vero, per abbracciarne una rassicurante versione potenziata.
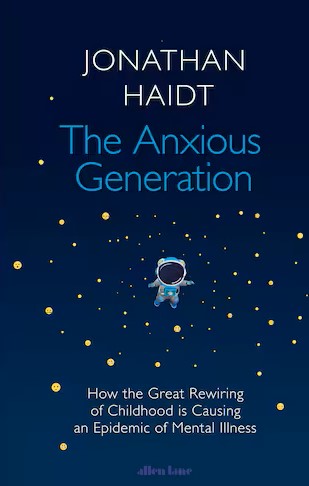
L’impressione è che i pre-adolescenti di oggi abbiano qualche difficoltà a mettere ordine tra i pensieri e, di conseguenza, a esprimerli: del resto la comunicazione social velocissima e bombardante non favorisce la nascita del pensiero critico e di idee originali, personali, ma di uno slang rapidissimo che ripropone nel mondo reale parole, tempistiche e temi da tik-tok.
Il multitasking richiesto dal bombardamento social, dove le informazioni sono tante e veloci, sta influenzando la neuroplasticità cerebrale delle nuove generazioni, che stanno cambiando fisiologicamente: provate a farvi raccontare da un ragazzino o da una ragazzina di 11/12 anni cosa fa coi suoi amici nel tempo libero, per esempio. Molto difficilmente riuscirete a trovare un filo logico in quello che dice, è come scorrere sul telefono una serie di reel. Ok, boomer, direte voi. Manco i nostri genitori ci capivano quando parlavamo. E così via, a ritroso. Giusto, ma non possiamo ignorare l’impatto di una connessione perenne in rete (impatto comprovato scientificamente, eh), quindi l’incomprensione non esiste solo a causa della fisiologica distanza generazionale.
Lo psicologo Jonathan Haidt, autore del saggio La generazione ansiosa, sostiene che gli smartphone e i social siano direttamente correlati con l’incremento di depressione, ansia e autolesionismo tra gli adolescenti, per esempio.
Non è un problema che riguarda solo la GenZ, comunque. Il paradigma della felicità perpetua, frutto di una narrativa preconfezionata e che nei social si autoalimenta, inganna anche le generazioni più vecchie (me compresa, eh).
Il paradigma della felicità perpetua e la perfezione dell’imperfezione
Il fallimento non è contemplato perché l’idea della sconfitta allontana dall’unica narrazione ammessa: la perfezione declinata in tutti i campi possibili. L’amore perfetto, le amicizie perfette, il viaggio perfetto, il viso e il fisico perfetto, la cultura perfetta, la musica perfetta, il cibo perfetto, l’umorismo perfetto, bisogna essere perfetti anche nell’accettazione delle nostre imperfezioni e quindi vai di post e pagine motivazionali su come imparare dai propri fallimenti, sui difetti fisici, problemi mentali e di salute (alcuni diventati perfino di moda, come le autodiagnosi di ADHD o autismo o disturbi della personalità. Non lo affermo io, tra i tanti, c’è questo studio dell’Università di Toronto che afferma che la gente si autodiagnostica disturbi su… Tik-Tok), perché esiste perfino un modo di essere malati perfetti, depressi perfetti, problematici perfetti.
Forse, per questo, siamo tanto attratti dall’Intelligenza Artificiale: ci permette di essere gli artisti, gli scrittori, i musicisti, i professionisti, gli esseri umani “perfetti” (anche nella malattia, nel dolore, nell’imperfezione) che questa nuova realtà richiede. Sull’Intelligenza Artificiale e, soprattutto, sulla connessione con il mondo dell’arte e del lavoro parlerò un’altra volta (c’è tanto da dire).
Il passaggio dall’infanzia all’età adulta e l’idea della felicità
Ultima riflessione, sul passaggio dall’infanzia all’età adulta. Tale transizione non è mai dolce, anzi, è necessario che non lo sia: un tempo questo momento era sancito da riti di passaggio duri, sanguinosi, definitivi. L’infanzia era abbandonata in maniera violenta anche per impedire ripensamenti: soltanto così si diventava adulti.
La transizione dall’infanzia all’età adulta è scandita in Grecia da vari “riti di passaggio”, attraverso i quali i giovani di entrambi i sessi sono gradualmente preparati ad assumere il ruolo di adulti (di cittadino e soldato o di moglie e madre) all’interno della società. Tali momenti di formazione spesso comportano l’allontanamento degli adolescenti dalla famiglia e dalla città e il confronto con un modello di comportamento che, seppur diverso da quello abituale, risulta tuttavia in primo luogo propedeutico al loro ruolo di adulti. Al loro ritorno da questo periodo di preparazione, essi sono reintegrati a pieno titolo nella polis.
Storia della civiltà europea, Umberto Eco
Poi c’erano riti di passaggio individuali e intimi che conducevano l’individuo dall’infanzia all’età adulta anche mediante la distruzione dei propri idoli personali: il padre, la madre, le leggi familiari, che poi sono quelle sociali ereditate. L’adolescente nasce e cresce in quella legge, poi la rifiuta, si vergogna delle radici, le distrugge, se ne crea di nuove. Poi torna, a riprendere ciò che di buono può servire per la sua nuova vita di adulto. Così avviene la progressione verso il futuro: distruggendo, conservando, ricostruendo.
Angosciante è invece l’idea di questa giovanissima generazione che viene su con idoli indistruttibili, in quanto irreali: non potendo distruggere un’idea di felicità, bellezza, successo, amore, amicizia così forti, così seducenti da non ispirare alcuna ribellione, come potranno creare la propria personale idea di felicità? E cosa accadrà alle vecchie generazioni, che stanno abbracciando questa nuova idea di perfezione, come se fosse realmente possibile?
Visto che Salerno Letteratura, quest’anno, dedicato a Kafka, si pone come obiettivo la ricerca delle domande giuste (che effettivamente sono molto più importanti delle risposte, a mio avviso), ecco la domanda giusta per concludere questo post:
Di cosa abbiamo davvero bisogno per essere felici?
