
Cesare Pavese scrive nel 1949 La luna e i falò e lo pubblica ad aprile del 1950: pochi mesi dopo, il 27 agosto, ingerisce una dose letale di barbiturici mentre si trova in una stanza (la 346) dell’Hotel Roma a Torino.
Da anni Pavese parlava di suicidio, ma non aveva mai avuto “il coraggio”, lo trova, o meglio trova l’incontestabile motivazione, dopo una serie di telefonate partite proprio quella sera dal telefono della sua stanza al Roma, tre o quattro donne che invita a cena, e da cui ottiene la stessa risposta: no. A malincuore quella di Fernanda Pivano, che non poteva lasciare il marito ammalato a casa.
La luna e i falò è, quindi, l’ultimo romanzo dello scrittore, dedicato all’ultima donna amata, Constance Dowling, l’attrice americana che non lo ricambiò mai. Un romanzo che nasce nella tristezza e nella disillusione, sentimenti che sono sublimati dalla struttura stessa del libro, che alterna a un passato idillico, il disincanto del presente. Tanti i temi che si intrecciano: l’antifascismo, la ricostruzione dopo la guerra, l’amore, l’amicizia, il tema del ritorno alle origini, il senso di distacco dal mondo.
Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Ma non è facile starci tranquillo.
La trama de La luna e i falò
Il solito disclaimer per chi odia gli spoiler, nonostante sia un classico stra-conosciuto e bla bla bla, ma comunque: attenzione, parlo anche del finale.
Anguilla, quarantenne, torna dall’America nelle Langhe torinesi, nel suo paese d’origine, che ricorda Santo Stefano Belbo, luogo di nascita di Pavese. Qui incontra il suo vecchio amico Nuto, col quale inizia un viaggio a ritroso nel tempo, dal momento in cui, neonato, è stato abbandonato sul sagrato del Duomo di Alba e poi adottato da Padrino e Virgilia fino a quando, deciso a trovare fortuna altrove, è partito per non tornare più.
I veri acciacchi dell’età sono i rimorsi.
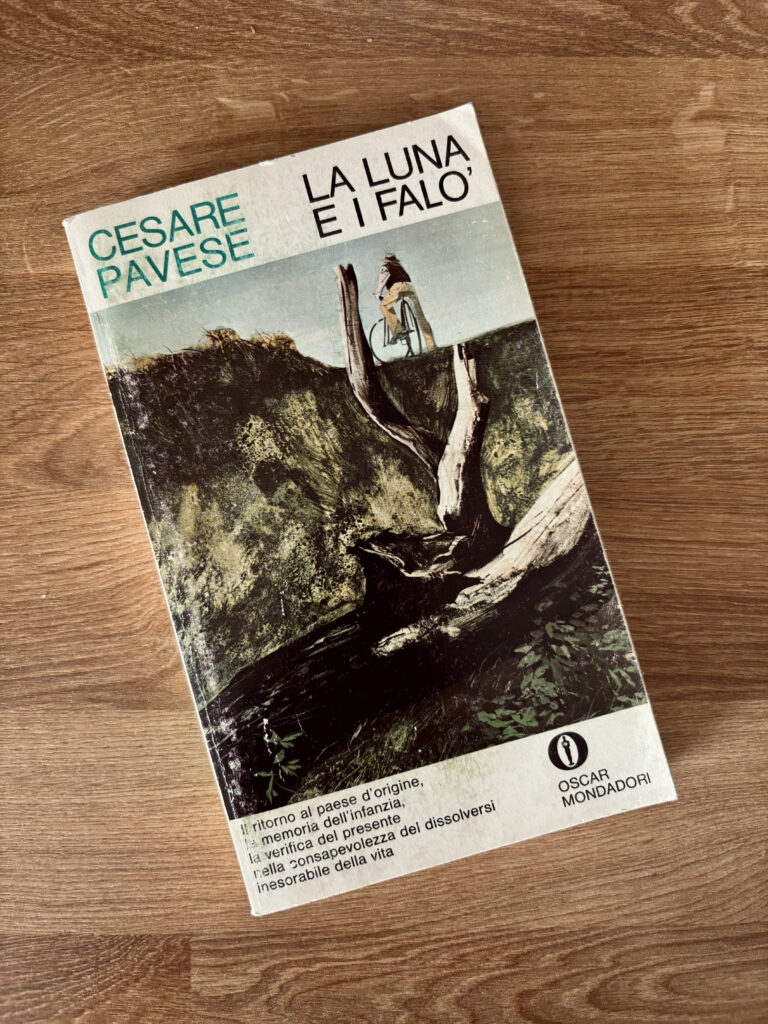
Trentadue capitoli in cui Pavese alterna passato e presente, in un botta e risposta nostalgico e intriso di disincanto: dalla fattoria della Mora, dove il piccolo Anguilla aveva iniziato a lavorare e dove aveva conosciuto sor Matteo e le sue tre figlie, Irene, Silvia e Santa, dove ha vissuto momenti di gioia, speranza, amicizia, fiducia nel futuro e senso di appartenenza, all’oggi freddo e impersonale della città dove è impossibile riprovare quei sentimenti.
Durante l’affannosa ricerca delle proprie origini, che costituiscono una zona di comfort nella quale sentirsi di nuovo a proprio agio, Anguilla deve infine accettare l’idea che, come diceva Fitzgerald ne Il grande Gatsby, “non si può ripetere il passato“. Paesaggi, colori, odori possono somigliare a quelli che portiamo nei ricordi, ma il tempo imprime una traccia indelebile sia sulle persone che sui luoghi.
Anguilla si rende conto che molti amici non sono sopravvissuti alla crudeltà della guerra, anche la bellezza di Santa è stata falciata da un destino crudele: la sorte della ragazza è rivelata soltanto alla fine del romanzo e, in qualche modo, determina la decisione di Anguilla di ripartire di nuovo. Il tentativo di riprovare quel senso di appartenenza, quella speranza nel futuro possibile soltanto in un luogo nel quale non ci sentiamo estranei, è fallito.
Ci vorrebbero dei comunisti non ignoranti, che non guastassero il nome.
Significato de “la luna e i falò”?
La luna nella cultura contadina è un elemento fondamentale, capace di regolare ogni aspetto della vita, ma anche di dettare il ritmo di tutte le attività umane. Nel racconto di Anguilla e nelle intenzioni di Pavese è il simbolo di un mondo lontano, di un passato idillico in cui ancora tutto era possibile. In effetti, questo è un bias cognitivo che ogni essere umano sperimenta: l’illusione di aver vissuto tempi irripetibili e migliori, la nostalgia di un passato in cui ogni cosa sembrava funzionare.
La luna, – disse Nuto, – bisogna crederci per forza. Prova a tagliare a luna piena un pino, te lo mangiano i vermi. Una tina la devi lavare quando la luna è giovane. Perfino gli innesti, se non si fanno ai primi giorni della luna, non attaccano.
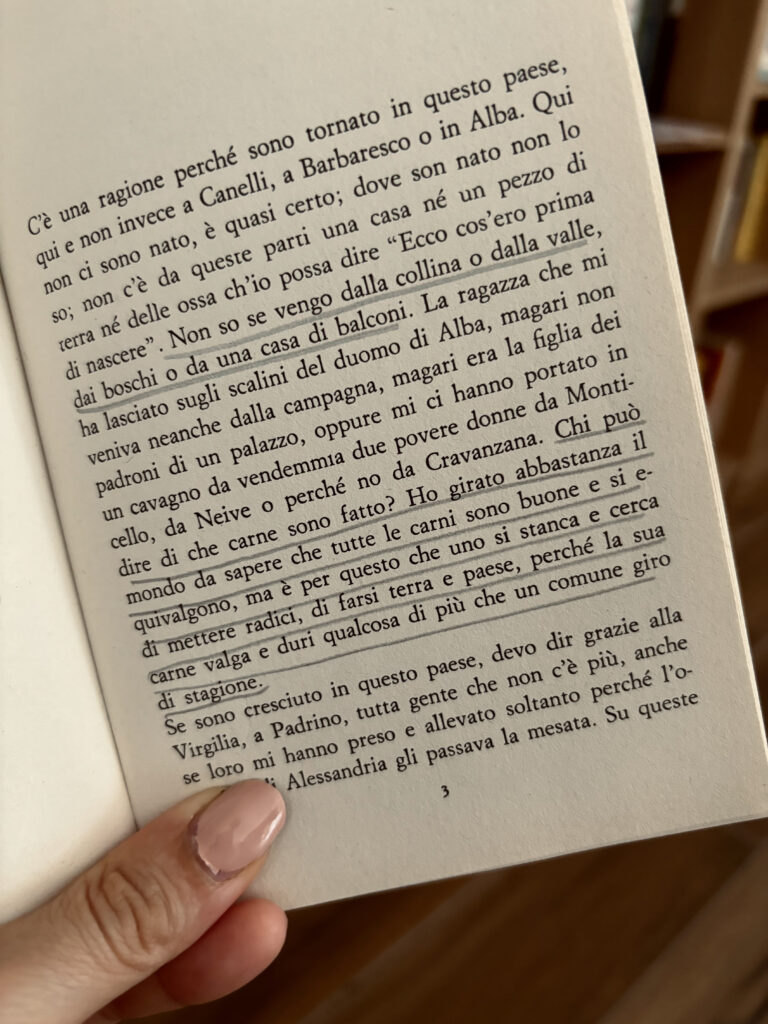
In questo romanzo c’è molto di più, però. Il passaggio dalla giovinezza, l’età delle belle speranze e degli ideali, all’età adulta è un trauma insanabile, perché nel caso di Pavese (e di Anguilla) si colloca in un dopoguerra complicato, in cui ancora ci si lecca le ferite, sia collettive che personali, queste ultime determinate da una personalità acuta, malinconica e insoddisfatta, tipica dell’Artista destinato a dipingere un mondo del quale non potrà mai davvero far parte.
Questo paese, dove sono nato, ho creduto per molto tempo che fosse tutto il mondo. Adesso che il mondo l’ho visto davvero e so che è fatto di tanti piccoli paesi, non so se da ragazzo mi sbagliavo poi di molto.
I falò sono un’altra testimonianza dell’arcadico passato, quando i fuochi venivano accesi per celebrare la fecondità della terra, secondo rituali di origine pagana, ma non solo: la potenza distruttiva del fuoco è protagonista della scena in cui il Valino, il nuovo proprietario della vecchia fattoria appartenuta al padre adottivo di Anguilla, dà fuoco alla dimora, uccidendo anche la nonna e la zia. Resta vivo solo Cinto, il figlio disabile, con il quale Anguilla ha stretto un rapporto profondo, padre-figlio.
Anche la storia della luna e dei falò la sapevo. Soltanto, m’ero accorto, che non sapevo piú di saperla.
Bruciata la casa d’infanzia, il passato di Anguilla si sgretola, mentre il fuoco da simbolo di vita diventa emblema di morte.
Alla fine del romanzo, Nuto racconta la morte di Santa, uccisa dai partigiani perché accusata di essere una spia nazista il cui corpo viene bruciato da Nuto stesso e altri per impedirne il vilipendio: la bellezza di Santa non subisce così la mortificazione della decomposizione, resta integra per sempre nella sua intensa tragicità, in un rituale funerario che ricorda quello tributato agli eroi dei tempi antichi. Il fuoco, prima vita, poi morte, diventa il sigillo di un passato luminoso ma irripetibile.
Fu cosí che cominciai a capire che non si parla solamente per parlare, per dire «ho fatto questo» «ho fatto quello» «ho mangiato e bevuto», ma si parla per farsi un’idea, per capire come va questo mondo.
